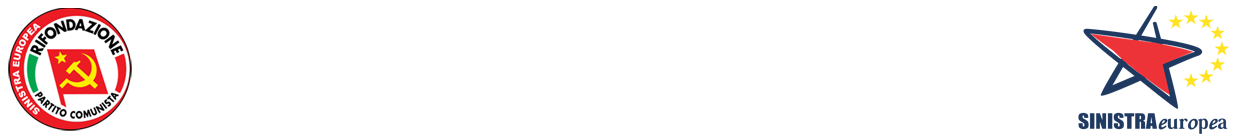Fermiamo questo PAT !
Gennaio 30, 2012A Padova: piangiamo con la ministra Fornero
Febbraio 10, 2012Lezioni dalla crisi. Elementi di una politica comunista
Ci diciamo spesso che la crisi ha confermato le nostre idee. Ma ciò è vero solo in parte. Ha confermato che il capitalismo, oltre ad essere iniquo, “non funziona”. Ma ci costringe a cambiare o aggiornare molte delle nostre più radicate convinzioni sul blocco sociale anticapitalista, e sullo spazio e gli obiettivi della sua azione. In sintesi, si può dire che il modello maturato a Porto Alegre e Genova agli inizi del nuovo secolo è ormai superato dai fatti: se ne vogliamo custodire e tramandare le acquisizioni fondamentali, soprattutto quelle relative alla democrazia ed alla molteplicità dei soggetti dell’emancipazione, dobbiamo inscriverle in un quadro concettuale del tutto nuovo. L’inefficacia di quel modello è evidente in primo luogo riguardo al populismo. La mobilitazione democratica delle associazioni altruistiche non è in grado di intercettare problemi, umori e linguaggi della parte più deprivata delle classi subalterne. Questa parte, fatta di lavoratori dipendenti a bassa qualificazione, di autonomi che sono in realtà più dipendenti dei primi (si pensi al lavoro dell’autotrasportatore, strettamente legato – a rischio della vita – ai tempi dell’impresa) e di ceto medio fortemente impoverito dalla crisi generale, si allea ad alcune frazioni, meno forti, della borghesia anche perché l’altra parte del popolo, quella composta di dipendenti ed autonomi ad alta qualificazione, si allea di fatto alla frazione forte, globalista ed europeista del nostro capitalismo. Rompere queste alleanze, e costruirne una, nuova, tra le diverse frazioni popolari, è decisivo per la lotta egemonica: lo si può fare solo se, tra l’altro, non ci si ritrae di fronte al linguaggio populista dei nuovi conflitti. E se si trovano figure unificanti che, pur radicate in una analisi di classe, sappiano rivolgersi ai diversi soggetti sociali ed alle diverse forme di vita degli stessi “proletari”. In questo quadro diviene opportuno parlare di sovranità popolare e nazionale, come collante di un nuovo blocco sociale e base di una nuova politica. Sovranità nazionale non è nazionalismo. E’ ridiscutere democraticamente quale sia lo spazio sovranazionale in cui il Paese di deve in ogni caso far parte. Qui si fa sentire un altro degli effetti della crisi: la progressiva dissoluzione dello spazio “globale” ed “europeo” nel quale eravamo soliti muoverci. Il multipolarismo è, in questo senso, uno spazio più favorevole della (presunta e parziale) globalizzazione, perché è l’unica griglia che possa sottoporre a controllo i flussi altrimenti devastanti dei capitali transnazionali. E non è più possibile trasformare l’Unione Europea in qualcosa di più paritario, cooperativo, democratico: è piuttosto necessario iniziare da subito a definire e costruire uno spazio mediterraneo-mediorientale in cui inserire il nostro Paese, prima come prospettiva da far balenare nelle trattative comunitarie, poi come concreta alternativa all’Unione monetarista. Infine se la crisi è davvero crisi di un intero modo di produzione e dei rapporti sociali e geopolitici che lo sostengono, la si può attraversare solo avendo un modello alternativo forte, che non può ridursi alla sola economia decentrata, sociale e cooperativa. Bisogna quindi ritrasformare il nostro comunismo da ideale ad idea, da lontano orizzonte a forma realisticamente possibile di una nuova produzione e di un nuovo Stato. Bisogna dunque pensare da subito ad un concreto socialismo, basato sull’intreccio tra proprietà pubblica, sociale e privata, gestito da uno Stato rinnovato, controllato da autonome istituzioni popolari. E quindi (ulteriore e forse più importante lezione della crisi) bisogna tornare a considerare la conquista-trasformazione del potere di Stato (non a caso confiscato in questi anni dai capitalisti, mentre noi si chiacchierava di “autonomia del sociale”) come uno snodo senz’altro non sufficiente, ma comunque assolutamente necessario di qualunque strategia popolare. Di queste cose si parla nelle note che seguono.
1.1. Conflitti anomali La crisi ha inaugurato, o portato alla massima evidenza, quello che propongo di chiamare “capitalismo a somma zero”. Se in precedenza, ed anche negli anni della crescita drogata, al massiccio aumento della ricchezza dei capitalisti corrispondeva un ben minore, ma comunque sensibile, aumento della ricchezza (reale o apparente) dei lavoratori, oggi avviene il contrario: il capitalismo sopravvive grazie all’incrudimento del tradizionale sfruttamento di classe e grazie all’espropriazione diretta delle risorse pubbliche e di ciò che prima spettava al lavoro (pensioni, servizi, beni comuni, ecc.). Oggi è sempre più chiaro che ciò che gli uni acquisiscono gli altri perdono: da ciò lo scatenarsi di numerosi e diversificati conflitti. Ma si tratta di conflitti ben diversi da quelli a cui eravamo abituati: alla lotta “ordinata” dei lavoratori sindacalizzati, delle associazioni civili e delle stesse aggregazioni reticolari dei lavoratori precari (più fluttuanti e instabili, ma pur sempre “disciplinate” in un quadro ideologico relativamente chiaro ed identificabile), si affiancano lotte di gruppi mai mobilitatisi prima d’ora o costretti a constatare l’inefficacia delle precedenti mobilitazioni: da ciò il carattere quasi sempre informe e spurio di queste lotte E’ bene dirsi con chiarezza che nessuna delle attuali forze della sinistra sociale e politica possiede al momento gli strumenti per comprendere queste lotte e per intervenirvi. Eravamo abituati alle lotte per il welfare, gestite dal nesso sindacato/partito/Stato. Queste sono poi state integrate o sostituite da lotte che andavano oltre il welfare e oltre la figura centrale dello stato sociale (il lavoratore stabile, maschio, adulto e sindacalizzato), ed erano gestite da associazioni orientate a culture dette postmaterialiste (femminismo, ambientalismo, diritti civili, pacifismo), ma comunque dotate di una solida tradizione culturale e passibili, pur non senza contrasti, di integrazione con l’ideologia della sinistra. Oggi siamo di fronte a lotte senza il welfare, prive, cioè, degli usuali canali di espressione politica e di trasmissione istituzionale: lotte dagli obiettivi troppo ristretti o troppo generici, dall’ideologia incerta, aperte a diverse declinazioni politiche o impolitiche. E’ illusorio tentare di ridurre l’ultimo, incerto “modello” a quelli precedenti. Per lungo tempo i tre modelli saranno compresenti e contrastanti: potranno essere unificati solo da un modello superiore. Soprattutto, è un grave errore prendere le distanze dalle ultime lotte tacciandole di populismo: nelle attuali condizioni è quasi inevitabile che le nuove mobilitazioni assumano un carattere populista, e fuggire il populismo significherebbe rifiutare di radicarsi nella realtà delle espressioni di massa. Bisogna starci dentro, comprenderle, distanziarsene, se necessario, solo dopo che si è fatto di tutto per trasformarle
1. 2. Questioni di classe Un ipotetico “fronte” dei lavoratori dovrebbe unificare figure notevolmente diverse. Le principali linee di divisione corrono tra stabili e precari, qualificati e dequalificati, uomini e donne, dipendenti, semiautonomi e autonomi, autonomi che servono imprese e autonomi che servono consumatori individuali. Gli intrecci tra queste diverse divisioni possono dar luogo a numerose combinazioni. Tutti questi lavoratori hanno di certo un avversario in comune: tutti sono infatti soggetti ad un processo di proletarizzazione, gestito dall’insieme del capitalismo italiano, che si traduce nella perdita di garanzie per gli occupati stabili, nella diminuzione delle prospettive dei precari, nella crescente sottomissione alle imprese committenti degli autonomi di seconda generazione, nel rapido declassamento degli autonomi di prima generazione. Al momento, però, tutti costoro (salvo poche e fluttuanti eccezioni) sono purtroppo alleati a questa o quella frazione delle classi dominanti. Una parte rilevante lavoratori sindacalizzati (soprattutto quelli pubblici) ed una parte rilevante dei precari o autonomi ad alta o media qualificazione (e, tra questi, soprattutto quelli addetti ai servizi alle imprese, che hanno più difficoltà ad evadere il fisco) sono di fatto alleate alla parte “forte”, europeista e mondialista del nostro capitalismo, nell’illusione che questa possa comunque consentire, oggi o domani, un nuovo sviluppo. Gli altri, molti dipendenti e precari dequalificati, disoccupati, lavoratori autonomi “tradizionali”, sono alleati alla parte “debole” e sedicente “nazionale” o regionalista (quando non ne sono elemento subordinato interno), perché più permeabili al discorso populista, più carenti di strutture di protezione, più propensi all’evasione fiscale. Date queste differenze, la costruzione di un blocco sociale che comprenda tutte le figure del lavoro oggi subalterno non può essere l’effetto di un progetto sindacale (anche se “one big union” capace di comprendere tutti è in futuro possibile) ma solo di un progetto politico di alto profilo che, partendo dal fatto che nessuna delle frazioni della classe dominante è in grado di assicurare un futuro, si presenti espressamente come rottura delle diverse alleanze subalterne con la classe dominante e come efficace riduzione del potere di queste ultime. Infatti, tutte le diverse proposte di uscita “a sinistra” dalla crisi (beni comuni, reddito di cittadinanza, rilancio della domanda di beni di consumo, politica industriale e via elencando) non hanno alcun senso se si concepiscono e si presentano come semplici alternative di politica economica e non, piuttosto, come causa ed effetto di una trasformazione dei rapporti sociali, di un’ alleanza delle diverse frazioni di una classe contro le diverse frazioni dell’altra, al fine di ridurre il potere dei dominanti.
1.3. Espropriare gli espropriatori Nessuno stabile sviluppo è possibile in Italia senza un pesante ritorno dell’intervento pubblico nell’economia e senza un immediato controllo democratico e popolare di questo intervento. Nulla di serio si può fare senza la sostituzione dell’attuale intreccio putrescente fra Stato ed interessi privati (nel quale naufragano anche molti gruppi della “società civile”) con la distinzione tra uno Stato autorevole (capace di riprendere la propria funzione di indirizzo e redistribuzione) e una società indipendente (fatta di associazioni capaci di controllare, criticare e all’occorrenza sostituire i gruppi dirigenti dello Stato). Ma tutto questo comporta necessariamente l’espropriazione (e comunque la drastica riduzione del potere) di quei gruppi privati a cui sono state svendute industrie e banche pubbliche, e che saccheggiano le amministrazioni centrali e periferiche con la spregiudicata gestione di appalti e concessioni. Parlare di nuova politica economica senza parlare di questo è illudere sé stessi e gli altri. Questa è la precondizione per un programma popolare che usi le risorse così ottenute per una politica programmata di innovazione, di ricostruzione sociale ed ambientale, di sostegno all’aggregazione delle piccole ed al dinamismo delle medie imprese e, anche per questa via, alla domanda di beni di consumo. Solo un programma del genere può unire i “piccoli” contro i “grandi” e contemporaneamente affrontare i problemi fondamentali del Paese.
1.4 Sovranità popolare (e nazionale) vs populismo Un simile programma può essere attuato solo da un forte governo popolare. Per accumulare le forze necessarie a costituire un tale governo è necessario iniziare a superare fin da ora la divisione fra i diversi gruppi di lavoratori. Tali divisioni sono di ordine sia materiale che simbolico e riguardano essenzialmente la questione fiscale, le forme di organizzazione e le forme di autorappresentazione ideologica. Puntando tutto su una generica lotta all’evasione i lavoratori sindacalizzati e quelli comunque “colti” appoggiano di fatto il progetto del capitalismo “forte” che intende stringere il cappio attorno ai piccoli evasori nella consapevolezza che le grandi imprese internazionalizzate possono facilmente giovarsi dei meccanismi di elusione. Pur sapendo che l’elusione fiscale delle grandi imprese potrà essere ostacolata solo dal loro passaggio nelle mani pubbliche, bisogna sin da ora presentare programmi fiscali che concentrino le politiche di recupero sulle ricchezze patrimoniali di ordine superiore (l’assenza di uno straccio di imposta patrimoniale grida vendetta), mentre aumentano gli sgravi alle piccole imprese (e soprattutto a quelle individuali) e riducono le sanzioni contro la piccola evasione. Questo è il perno di una politica di riconquista di risorse da parte dei ceti popolari (fatta anche di cancellazione delle grandi opere, delle spese militari, della privatizzazione dei beni comuni) che serva ad unire questi ceti, evitando con estrema cura di costringere il piccolo evasore ad allearsi col grande. Nell’emersione dei nuovi conflitti la partita dell’egemonia si gioca, oltre che sulla questione dei programmi, sulla capacità di essere i primi a proporre forme di organizzazione efficace. Il modo in cui questo conflitti vengono organizzati oggi condizionerà in maniera decisiva il modo in cui si svilupperanno domani, entrerà a far parte del DNA di un intero movimento popolare. Vanno certamente tentate modalità organizzative di tipo sindacale. Ma l’iniziale eterogeneità delle figure e degli obiettivi suggerisce piuttosto, come modello organizzativo di base, i comitati popolari contro la crisi. Tali comitati possono sorgere ex novo, o possono appoggiarsi a precedenti strutture sindacali e partitiche, ma devono in ogni caso sia accogliere l’eterogeneità attraverso il massimo ricorso alla democrazia interna, sia superarla attraverso il mutualismo e la costruzione di una ideologia unificante. Tale ideologia non può essere l’ideologia classista a cui siamo abituati, e nemmeno può nascere dall’integrazione tra classismo e associazionismo civile che è stata tentata dal movimento altermondialista, ma non è penetrata nella grande massa dei ceti subalterni. Deve piuttosto essere un’ideologia popolare, dove “popolo” indica tutti coloro che lottano non contro la libertà altrui, ma per la propria libertà e dignità (Machiavelli), tutti coloro che rivendicano dignità e libertà non contro altri segmenti del popolo (come vorrebbe il populismo), ma solo contro i potenti. “Popolo”, oggi, può raccogliere ed unire più di “classe”: perché non è solo la classe a mobilitarsi, perché molti segmenti crescenti della classe si concepiscono più come popolo che come lavoratori organizzati, e soprattutto perché anche la mobilitazione di classe, per porsi all’altezza di uno scontro che ribalta la costituzione formale e materiale del Paese, deve presentarsi come rivendicazione della sovranità popolare. Non si tema di perdere, con questo spostamento lessicale, la capacità di nominare e contrastare il capitalismo, anzi. In alcune fasi storiche, come nella seconda metà del XX secolo, lottare come classe significava immediatamente opporre un’altra economia politica all’economia politica dominante. In altre fasi, però, lottare come classe può significare allearsi coi propri padroni, su base aziendale o regionale, contro altri padroni e altri segmenti del proletariato: ed è anche a causa di questa tendenza subalterna del comportamento di classe che Marx ha potuto affermare che, lottando per abolire il capitalismo, il proletariato abolisce sé stesso in quanto classe. Per lottare contro l o strapotere del capitalismo odierno non si può far affidamento solo sull’iniziativa di lavoratori strutturalmente indeboliti, e si devono piuttosto mobilitare tutte le risorse politiche, giuridiche ed istituzionali che hanno in passato arginato il capitalismo stesso. Il “riassunto ideologico” dell’epoca attuale, la chiave per aggregare strati sempre più vasti di cittadini, deve essere quindi la lotta per la sovranità popolare. E ciò implica immediatamente la lotta per la sovranità nazionale. Sovranità popolare non significa dittatura della maggioranza e rottura dello Stato costituzionale di diritto (come, di nuovo, vorrebbe il populismo), ma sottrazione del potere di decidere alle oligarchie finanziarie (Ferrajoli). Sovranità nazionale non significa affatto nazionalismo, ma difesa di uno spazio in cui sia possibile assumere decisioni democratiche e quindi ridiscutere liberamente il modo in cui si intende essere partecipi di uno spazio sovranazionale. Ma poiché a parlar di nazione subito si affacciano pericolosi equivoci, che vanno dal neofascismo alle sciocchezze “rossobrune” e da queste ai più immediatamente pericolosi governi di unità nazionale per la salvezza della Patria e la dannazione dei lavoratori, converrà, su questo punto, essere più precisi.
2.1. Multipolarismo Dobbiamo abbandonare decisamente l’idea della “globalizzazione dal basso”, ossia l’illusione che la globalizzazione possa essere democratizzata. Il movimento antagonista deve continuare a costituirsi globalmente, ma la sua politica non può più essere globalista. Infatti la globalizzazione è essenzialmente liberalizzazione completa dei movimenti del capitale, e questa crea un continuo dumping sociale che distrugge l’organizzazione dei lavoratori e dei cittadini e dunque rende impossibile la democrazia. Volere la globalizzazione democratica è come volere il capitalismo democratico, ossia qualcosa che era assai difficile ottenere nell’epoca del capitalismo nazionale e del patto socialdemocratico, e che diventa impossibile ottenere adesso, nell’epoca del capitalismo “assoluto” e “senza compromessi”, assoluto perché globalizzato. L’unica strada per tentare la costruzione di un ordine economico politico cooperativo e pacifico è il multipolarismo, ossia la creazione di vaste regioni economico-politiche che non eliminino i flussi di capitale ma li sottopongano a vincoli e a contrattazioni di tipo politico, rendendo così possibili al proprio interno scelte pro labour. E’ una via irta di rischi: protezionismi, guerre (che peraltro sono il leit motiv della globalizzazione). Ma è l’unica condizione che possa assicurare gli equilibri necessari alla creazione di una moneta comune che non sia strumento dell’egemonia di un polo (come avviene col dollaro) ed alla costruzione di un effettivo diritto internazionale (Ferrajoli) che non si limiti ad assicurare il libero movimento del capitale e a giustificare tutte le più infami guerre. Per ridurre i rischi e favorire le possibilità positive del multipolarismo, il movimento antagonista, reso più forte dalla possibilità di crescere, in ciascuna regione, al riparo dalla violenza dei flussi di capitale incontrollati, deve però continuare ad esprimere la propria vocazione globale, ed anzi la deve rendere più forte concretizzandola con la costruzione di una V Internazionale (Samir Amin), più vicina al pluralismo della I che al centralismo della III, ma capace di darsi quegli obiettivi politici unitari che il Forum Sociale Mondiale non vuole e non può darsi.
2.2. Oltre l’Europa L’Unione Europea, come progetto realmente unitario e unificante, è finita. Nel futuro avremo l’Europa “a due velocità”, o l’esplosione dell’Unione. Ciò equivale a dire che i PIIGS saranno condannati ad una lunga recessione ed alla definitiva integrazione subalterna nelle economie “forti”, e che i cittadini di tutto il continente saranno condannati a pagare un modello fondato sulle esportazioni. In queste condizioni l’ “altra Europa”, l’Europa “sociale”, costruita “dal basso” è una pura illusione: è impedita dalla struttura istituzionale dell’Unione, dalla cultura delle sue burocrazie, dall’orientamento delle classi dominanti delle nazioni più forti, dall’inesistenza di una realistica alternativa socialdemocratica, dall’inesistenza di un efficace movimento popolare continentale, reso ancor più difficile dalle prospettive di recessione. Dobbiamo dunque uscire dall’Europa? No, o comunque non subito. Dobbiamo però uscire dall’ ”europeismo senza condizioni” che ci accomuna all’ideologia ed alla politica delle frazioni “forti” del capitalismo italiano. Queste frazioni hanno scelto decisamente l’Europa, costi quel che costi, essenzialmente perché essa consente loro di operare, grazie alla coercizione del “vincolo esterno”, quelle politiche antipopolari rese altrimenti impossibili dal loro storico difetto di egemonia: il governo Monti è la massima espressione di questa strategia. Anche noi abbiamo scelto l’Europa, ragionevolmente convinti che un progetto di tipo socialista fosse possibile solo in un ambito sovranazionale. La convinzione era giusta, ma l’ambito scelto no: continuare ciononostante ad insistere sull’ “altra Europa” equivale, in questa situazione, ad aderire all’ “europeismo senza condizioni”. Dobbiamo quindi puntare su una soluzione nazionalista? No. Il nazionalismo non è sempre e comunque un male. Quando serve a reprimere la lotta di classe interna sviandola nella lotta contro presunti nemici esterni è un male. Ma quando la repressione della lotta di classe avviene attraverso una particolare forma di internazionalizzazione, il nazionalismo può essere, momentaneamente, una parte della risposta: tutte le più importanti esperienze progressive di questi anni hanno una qualche componente nazionalista, quando non indigenista-comunitarista (Venezuela, Colombia, in parte lo stesso Brasile). Ma il nazionalismo non è una risposta valida per l’Italia, sia per la cultura fortunatamente antisciovinista del Paese sia, e soprattutto, per la sua struttura economica: ogni pur parziale politica nazionalista deve essere infatti compensata dall’esportazione di una qualche risorsa peculiare del Paese, particolarmente richiesta dal mercato mondiale, come l’energia (Venezuela, Colombia) o i prodotti agricoli (Argentina), ma di tali risorse noi siamo privi. Che fare, dunque? La nostra unica speranza, che peraltro si riallaccia a storiche tendenze del Paese, sta nella creazione di un nuovo spazio sovranazionale, centrato sul mediterraneo, aperto alle dinamiche progressive del nordafrica e del medioriente e ponte verso l’Asia e la Cina. Uno spazio estremamente ricco di capitali, di lavoro, di energia, il cui sviluppo sarebbe anche condizione per la rinascita del nostro Mezzogiorno, e quindi del Paese intero. La costruzione di questo spazio (che può avere diverse varianti – si vedano al proposito le tesi di Bruno Amoroso o di Luciano Vasapollo – e che deve essere iniziata da subito, anche dall’opposizione) deve essere giocata in un primo momento all’interno delle dinamiche europee, come elemento che aumenti il nostro potere di negoziazione, ma deve essere vista, in prospettiva non remota, come alternativa all’Unione Europea ed alla sua deriva monetarista e recessiva.
2.3. Dignità del lavoro, dignità del Paese Non dobbiamo, dunque, essere nazionalisti. Eppure dobbiamo reinserire nel nostro lessico la “nazione” come categoria economica, politica ed ideologica. Non la nazione come etnia, come deposito di una storia o come comunità linguistica, ma la nazione come spazio di diritti, come luogo di possibile decisione democratica di contro alla chiusura tecnocratico-capitalistica degli spazi sovranazionali. La nazione come punto di partenza di una politica e di una dimensione sovranazionale alternativa, e non come punto di arrivo di una illusoria autarchia. Come notava Gramsci, non è detto che una forma storicamente superiore di Stato, più conforme all’evoluzione economica mondiale, sia necessariamente positiva anche per i lavoratori, e quindi non è detto che ogni passo indietro rispetto a quella forma sia necessariamente reazionario. Non è detto che la globalizzazione e l’Unione Europea, astrattamente progressive rispetto alla nazione ed al nazionalismo, siano progressive anche concretamente: ed in realtà mostrano di essere regressive. Lo spazio nazionale può dunque momentaneamente tornare ad essere progressivo, ma a due condizioni: 1) che sia definito a partire dagli interessi popolari e 2) che si apra immediatamente ad una forma di cooperazione sovranazionale, costituendo una delle aree regionali dell’equilibrio multipolare. Dobbiamo quindi prendere le mosse dagli interessi del blocco sociale a cui ci riferiamo, e subito dopo trovare il punto di intersezione fra questi interessi ed i problemi oggettivi del Paese (quelli, per intenderci, che ogni classe che voglia divenire egemone deve, a suo modo, risolvere). Gli interessi popolari si riassumono sostanzialmente, oggi, nella riconquista della dignità del lavoro (nuova e stabile occupazione, riconoscimento del ruolo centrale del lavoro nel processo produttivo), in un mutamento della struttura dei consumi che punti a soddisfare i bisogni essenziali, in una tutela generale dell’ambiente naturale e sociale. I problemi oggettivi del Paese si riassumono nella necessità di operare un salto verso l’economia della conoscenza e di inserirsi in uno spazio sovranazionale paritario che consenta una relativa sicurezza energetica, un interscambio di lavoratori, merci e capitali, una salvaguardia della pace. Ebbene, le classi attualmente dominanti non sono in grado di affrontare seriamente i problemi nazionali perché i capitalisti che si sono appropriati delle aziende e delle banche pubbliche (che erano ormai degenerate, ma costituivano pur sempre un potenziale volano economico ed innovativo) preferiscono l’arricchimento patrimoniale all’investimento produttivo, gestiscono le imprese con capitali esigui, sufficienti a controllarle, ma non a svilupparle (fatte le debite proporzioni, il “nanismo” industriale è malattia non solo delle piccole imprese, ma anche di quelle grandi), e perciò, quando investono in produzione e non in speculazione, preferiscono la facile via del supersfruttamento del lavoro dell’ ambiente e della ricchezza pubblica a quella più onerosa dell’innovazione e del rischio imprenditoriale. Inoltre, tutto ciò si traduce in una gracile egemonia sociale, che cerca sostituti o nel vincolo esterno europeo, o nel lassismo fiscale, nelle immaginarie comunità regionali, o in uno pseudonazionalismo che si trasforma rapidamente in servilismo ad ogni seria crisi internazionale. Il governo Monti, divenuti momentaneamente inservibili in nazionalismo berlusconiano ed il regionalismo, esercita chiaramente un’egemonia per vincolo esterno e ne approfitta per proseguire nella via maestra del capitalismo italiano, liberalizzando davvero solo il mercato del lavoro, i servizi pubblici e (meno) qualche ordine professionale e qualche area residuale, lasciando per il resto sostanzialmente intatte qualche le concentrazioni di potere industriale e finanziario. Una via maestra che riproduce le condizioni che impediscono l’innovazione: le odiose tirate contro il “posto fisso” occultano il fatto che l’innovazione richiede rapporti stabili tra lavoro ed impresa, “fidelizzazione” del lavoratore come condizione di una lettura coerente del processo di lavoro, delle trasformazioni necessarie, della loro implementazione. E’ solo un esempio, ma è il più importante: la dignità del lavoro è condizione della dignità del Paese perché l’innovazione è essenzialmente effetto di un clima sociale realmente cooperativo; l’innovazione sociale, insomma, è condizione dell’innovazione tecnologica. Inoltre, la sostituzione, nei settori strategici, dell’intervento pubblico a quello privato non è solo sostegno all’occupazione, ma superamento della scarsità di capitali che impedisce l’innovazione stessa. E infine, la dignità del lavoro coincide con la dignità del Paese perché impone la ricerca di uno spazio sovranazionale cooperativo che superi l’attuale subalternità italiana. E’ in tal modo che un programma popolare diviene programma nazionale (nazionale perché popolare – Gramsci), diviene nuova politica internazionale e aumenta, anche per questa via, la propria capacità di egemonia all’interno del Paese stesso. Un programma popolare e nazionale può radicarsi stabilmente all’interno di una determinata formazione territoriale solo se prende le mosse da un’analisi delle classi e del loro rapporto con le dinamiche internazionali. Ed è quanto abbiamo cercato di tratteggiare in queste note. Ma tutto ciò non basta. In situazioni di crisi epocale, come quella che stiamo vivendo, si confrontano e si confronteranno ancor di più, sulla scena globale, diversi possibili modelli di soluzione della crisi stessa. Noi dobbiamo avere un nostro modello alternativo, per non restare prigionieri di quelli altrui. Dobbiamo insomma avere una più precisa e concreta idea di quel comunismo e di quel socialismo di cui sempre parliamo e di come la loro pur parziale realizzazione si intrecci con i conflitti mondiali. Senza questa idea non saranno possibili né programmi di fase né programmi immediati, e la stessa prospettiva popolare e nazionale si troverà sguarnita di fronte alle evoluzioni ed alle precipitazioni della crisi. Dobbiamo avere, insomma, un chiaro obiettivo storico, ed organizzare le nostre forze e la nostra politica in relazione ad un tale obiettivo. Propongo, in conclusione, alcune prime riflessioni su questo punto.
3.1 Crisi, capitalismo di Stato, socialismo Il nostro obiettivo storico deve tornare ad essere il comunismo. E poiché quest’ultimo può esistere solo come combinazione concreta di produzione sociale e privata, di democrazia autorganizzata e rappresentativa, di società autogovernata e di Stato costituzionale di diritto, è al socialismo che dobbiamo puntare come forma effettiva di realizzazione della tendenza comunista. Di fronte alla crisi non basta, infatti, rivendicare diritti, democrazia, politiche economiche progressive. La crisi non dipende solo dalla finanza, ma anche da una struttura proprietaria delle imprese; non deriva solo dal deficit di domanda “popolare”, ma anche dalla diminuzione degli investimenti industriali, sempre meno profittevoli, nonostante la continua compressione del lavoro, dato l’alto costo dell’innovazione, della ricerca e della commercializzazione. Solo rastrellando la maggior massa possibile di ricchezza sociale il capitalismo può uscire da quest’ultima, cruciale, difficoltà. L’ha fatto con l’intervento degli “investitori istituzionali” (fondi pensione, ecc.), ma questi hanno piegato le imprese alla logica del ritorno immediato per gli azionisti, in spregio di qualunque logica produttiva. L’ha fatto con la creazione di capitale fittizio (di “denaro privato”) attraverso la finanziarizzazione, e si è visto come è andata a finire. Ora lo fa, e lo farà sempre di più in futuro, ricorrendo direttamente allo Stato, per creare moneta, per drenare ricchezza popolare (la c.d. crisi del debito pubblico e le conseguenti misure recessive), per salvare e gestire le imprese che richiedono maggiore capitale e così orientare l’intera produzione. Questo aperto ricorso allo Stato, dopo decenni di ricorso occulto alla mano pubblica, è il riconoscimento de facto della giustezza della previsione di Marx: ad un certo punto la produzione diviene talmente socializzata da non poter più essere gestita dal singolo capitale e da richiederne l’assunzione diretta da parte della società stessa. Solo che, in assenza di un movimento socialista internazionale, questo riconoscimento avviene in forma capitalistica, e si presenta come un colossale spostamento di reddito dai cittadini al capitale, come completo soggiogamento dello Stato al capitale stesso, o come creazione di una burocrazia statale che assume in prima persona il compito della valorizzazione capitalistica. Socialismo per i padroni, mercato per i lavoratori! : questa è la parola d’ordine del nuovo capitalismo di Stato. A noi tocca invece iniziare e condurre con decisione la battaglia per far sì che tutto ciò che funziona grazie alle risorse sociali venga proporzionalmente gestito dalla società stessa, si trasformi in proprietà pubblica, sociale e comune attraverso lo spossessamento dei capitalisti. Questo, e niente di meno. Non basta rivendicare i beni comuni se non si comprende che il capitale stesso è un bene comune in quanto prodotto sociale, ed è quindi giusto riappropriarsene. Non basta rivendicare l’economia sociale e cooperativa, se questa lascia intatte le grandi imprese e la loro logica. Non serve la retorica della lotta sociale, l’autocelebrazione delle capacità creative della cooperazione, della moltitudine, del lavoro, se il lavoro vivo non si riappropria di quel lavoro morto (macchinari, strutture organizzative, denaro: ossia imprese e banche), che pur essendo un suo prodotto, continua ad ergersi contro il lavoro stesso come una potenza estranea ed ostile (Marx). Nessun errore sarebbe più grave, di fronte al ritorno del capitalismo di Stato, del reagire con la solita contrapposizione tra Stato e società, rifugiandosi nella seconda per tentare di “condizionare” il primo.
3.2 Importanza dello Stato Lo Stato contemporaneo è un insieme di istituzioni pubbliche e private, nazionali, sovranazionali e regionali che, attraverso norme legali o regole pattizie stabilite tra organizzazioni private aventi funzioni pubbliche, assicura una relativa continuità alla riproduzione di determinati rapporti sociali. Questa dispersione, questo polimorfismo dello Stato ha fatto risorgere tra di noi l’idea che lo Stato sia irrilevante, o non esista più, o (in singolare coincidenza col liberismo radicale) che in ogni caso non dovrebbe più esistere. La crisi, conviene ripeterlo, ha tolto ogni credibilità a queste tesi. Nelle fasi ascendenti si può delegare alle strutture sovranazionali una buona parte delle decisioni, anche per allontanare l’attenzione dai luoghi fondamentali della politica. Ma quando il gioco si fa duro, le cose cambiano, e molto. Nel momento decisivo della crisi stessa gli apparati pubblici nazionali sono tornati ad essere il perno dello Stato intero e della stessa economia, in quanto primi depositari della possibilità di battere moneta socialmente validata (mentre la gran massa della moneta “privata” – titoli, derivati, ecc. – mostrava d’essere carta straccia o puro segno elettronico) e di drenare risorse spostandole massicciamente da una classe all’altra. Senza il loro saldo potere sui governi nazionali, pazientemente costruito mentre noi teorizzavamo l’irrilevanza del “politico”, le stesse classi capitalistiche transnazionali non sarebbero riuscite ad operare quel colossale spostamento di reddito dal lavoro al capitale (salvataggi bancari, emissioni di moneta a debito ripagate con tagli al welfare) che ha loro consentito di sopravvivere e addirittura di costituire concentrazioni di capitale più forti di quelle sono state concausa della crisi. Se ne deve dedurre che senza condizionare, influenzare, conquistare e trasformare il potere dei governi nazionali (come premessa della presa e trasformazione degli apparati statali in generale) le classi subalterne resteranno per sempre tali. Il che comporta (oltre alla consapevolezza che si tratterebbe comunque solo di una parte della trasformazione necessaria) che la politica delle classi subalterne non può consistere solo nella crescita progressiva della democrazia sociale e delle sue istituzioni autorganizzate, ma deve tornare ad essere anche azione coordinata per spostare, in congiunture determinate, i rapporti di forza tra le classi al fine di conquistare i diversi “pezzi” di Stato di volta in volta decisivi, ed in particolare i governi nazionali (Lenin). Chi, ciononostante, continua ad insistere sull’autonomia del sociale, dimentica che l’idea stessa (e la pratica) di autonomia del sociale, nelle sue forme contemporanee, nasce proprio come effetto paradossale dell’espansione del Big Government: solo sulla base della sicurezza e delle risorse fornite dallo Stato la società ha potuto in molti casi “far da sé”. Ed è proprio perché le erogazioni del welfare erano da tempo garantite, tanto da sembrare ovvie e addirittura “naturali”, che la società ha potuto pensare, ad un certo punto, di essere del tutto autonoma dallo Stato e di poter sussistere senza l’ausilio di politiche pubbliche, dunque autoritative, di redistribuzione. Ma quando queste politiche cessano, ed anzi assumono segno inverso, si vede chiaramente che senza una trasformazione diretta dell’orientamento dello Stato le organizzazioni sociali sono condannate ad un semplice ruolo di resistenza. Un ruolo comunque importantissimo, certo: non solo perché senza resistenza non c’è controffensiva, ma perché è pur sempre fuori dallo Stato, e quindi nelle autonome istituzioni sociali, che deve e può costituirsi un soggetto antagonista, ossia capace di elaborare ed in parte sperimentare rapporti sociali alternativi. Fuori dallo Stato oggi (perché è Stato capitalistico) e domani (perché anche uno Stato socialista, pur democratizzato, tenderebbe inevitabilmente a riprodurre relazioni gerarchiche): ma fuori dallo Stato per accumulare le forze ed il sapere necessari a conquistare e trasformare lo Stato stesso, rimanendone pur sempre distinti. Il nostro “comunismo di società” quindi, pur facendo sempre perno sull’autonomia delle istituzioni di movimento, non può limitarsi ad essere un pensiero del “non-Stato” e deve divenire anche pensiero del nuovo Stato, ossia della nuova combinazione di organi, pubblici e no, capaci di assicurare continuità (Gramsci) alla nuova forma di riproduzione sociale.
3.3 Programmi per il tempo breve, medio e lungo Posso ora riassumere il senso del mio ragionamento. Come parte potenziale di una V Internazionale tutta da costruire, il movimento comunista italiano (e con esso tutta la residua sinistra) deve battersi per un programma immediato di ricostruzione di un blocco sociale anticapitalista, per un programma intermedio di governo popolare, e in prospettiva per un programma socialista. Nella cornice della rivendicazione della sovranità popolare e nazionale, il programma immediato punta a rompere l’alleanza subalterna delle diverse frazioni popolari con le diverse frazioni capitaliste. Lo fa proponendo una forte redistribuzione del reddito dall’alto in basso, con particolare attenzione a non colpire ulteriormente le categorie intermedie in via di proletarizzazione, che sono la vera posta in gioco di una lotta per l’egemonia. Lo fa iniziando a costruire autonome istituzioni di movimento in cui si unifichino i diversi strati popolari. E proponendo un ripudio delle politiche europee, un nuovo spazio sovranazionale per il Paese, un immediato “piano del lavoro” per la manutenzione del nostro paesaggio ambientale e sociale e per le connesse innovazioni. Il programma di un governo popolare, la cui possibilità dipende dalla creazione del blocco antagonista e dall’acutizzarsi della crisi d’egemonia del capitalismo italiano ed europeo, inizia a modificare la struttura della produzione, soprattutto grazie ad una parziale espropriazione delle grandi concentrazioni capitaliste ed all’intervento diretto ed indiretto dello Stato, sottoposto a tutte le forme possibili di controllo dal basso ed integrato all’economia sociale e cooperativa. Sulla base di questa modifica trova le risorse per rilanciare innovazione, occupazione e domanda interna. Contemporaneamente lavora in concreto per un nuovo spazio sovranazionale, negoziando duramente con l’Unione Europea e preparando un’alternativa ad essa. Un simile governo popolare non può far altro, in una prima fase, che dar vita ad un capitalismo di Stato democratico, che, pur rafforzando la posizione dei cittadini e dei lavoratori, non riuscirà a modificare che parzialmente il fine generale delle imprese (ossia la spinta alla massima valorizzazione possibile), la forma salariata del lavoro, la forte diffusione della proprietà privata anche oltre i settori in cui essa è comunque opportuna. Esso deve essere quindi considerato come un momento di accumulazione delle forze per un salto ulteriore, i cui tempi e le cui forme non possono essere predeterminati, ma che l’evolversi della crisi mondiale potrebbe rendere necessario, oltre che possibile. La sua evoluzione verso il socialismo potrà essere misurata, oltre che dalla capacità di espropriare gli espropriatori aumentando, e non riducendo, democrazia e pluralismo, dalla risposta alle seguenti sfide: riduzione della spinta alla massima valorizzazione del capitale, possibile solo in uno spazio multipolare che freni la mobilità del capitale stesso; riduzione della dipendenza dei cittadini dal lavoro salariato, attraverso la riduzione del tempo di lavoro subalterno, l’aumento del tempo di lavoro sociale gratuito e la conseguente fruizione gratuita di beni e servizi; sviluppo di un apparato amministrativo dialogico, la cui azione sia basata sul principio del coinvolgimento obbligatorio dei soggetti sociali nella definizione delle politiche che li riguardano; crescita di istituzioni popolari, dotate di capacità e potere di controllo sulle imprese e sullo Stato, ma necessariamente autonome dallo Stato in quanto fonte continua di rinnovamento dei gruppi dirigenti, strumento di contrasto alle inefficienze ed alle involuzioni oligarchiche e burocratiche dello Stato stesso; elaborazione statuale e sociale di una economia programmata che orienti l’innovazione non verso la continua creazione di beni di consumo, ma verso tecnologie di gestione razionale delle risorse, delle energie, dell’ambiente sociale e naturale (tecnologie che diverranno in futuro decisive anche nel mercato mondiale) . Si può certamente avere un’altra idea di socialismo ed un’altra idea di società. Ma chiunque voglia affrontare la crisi per quello che essa effettivamente è deve proporre comunque una visione forte del futuro, l’idea di una nuova situazione per la quale lottare. Solo così un partito comunista potrà tornare ad essere qualcosa di più del ricettacolo di differenti famiglie politiche, del vessillifero di qualche generoso e confuso ideale, e potrà tornare ad essere un’idea che diviene organizzazione, e quindi senso comune.
Autore: MIMMO PORCARO